Pragmatismo o ideologia. Ambizioni e realtà. Blocchi geopolitici e sviluppo tecnologico. Per frenare le emissioni di CO2, il cui ritmo di crescita non accenna a diminuire, servirebbe l’unità di intenti. Eppure, la governance globale, riunita a Dubai per la Cop2028, ha dovuto fare i conti con il pessimismo della ragione. Perché l’anno 2023 è senza dubbio quello della grande frenata. Altro che emergenza climatica, qui preoccupano la tenuta sociale ed economica. Anche in Occidente.
Con i debiti pubblici in aumento, nella morsa degli alti tassi di interesse che ne amplificano i costi. E il ceto medio travolto dal carovita che erode i risparmi e induce i governi a sostenerne la domanda alimentando la spesa pubblica.
Per questo l’impatto non può che trasferirsi sulla finanza, che abilita gli investimenti però sconta in anticipo i cambiamenti. Non sorprendono, dunque, i guai finanziari di alcuni grandi aziende del settore eolico come Siemens Energy e Orsted. Non stupisce nemmeno il rallentamento della produzione di veicoli elettrici da parte di Ford e General Motors, due big dell’auto Usa, perché il ceto medio non può comperarle.
Certo colpisce la decisione dei governi, inglese e canadese in primis, di rallentare sulla decarbonizzazione. La linea di faglia dei conflitti militari tra i due blocchi poi amplifica la diffidenza. Il rinverdirsi del focolaio in Terra Santa, dopo la guerra di trincea in Ucraina, segnala che il mondo non può prendere di petto, come dovrebbe, la sfida che tutti abbiamo davanti: rallentare il riscaldamento globale destinato a superare i due gradi centigradi, una soglia che porterebbe dritta alla catastrofe.
Le minacce economiche si intersecano con quelle geopolitiche e ambientali. E si trasferiscono sui mercati finanziari. Così cominciano ad attribuire prezzi più ragionevoli ai titoli green. Uno degli indici più liquidi è l’Exchange Traded Fund (ETF) iShares Global Clean Energy, un fondo gestito da BlackRock. Replica l’andamento di un paniere di circa cento aziende del settore delle energie rinnovabili. Le quotazioni sono in caduta del 34% da inizio anno. Lo stesso indice azionario americano più importante, S&P 500, ha fatto segnare una crescita del 16%, in distonia evidente col precedente.
Anche le emissioni di obbligazioni private legate alle energie pulite hanno subìto una flessione. Nel 2021 erano state emesse sul mercato bond per 608 miliardi, nel 2022 si è scesi a 541 miliardi di dollari e il 2023 chiuderà attorno ai 510 miliardi. Le società di idrocarburi, al contrario, hanno fatto segnare nel 2022 e 2023 profitti da record. La grande liquidità a disposizione dei colossi del petrolio ha finito per favorire le fusioni.
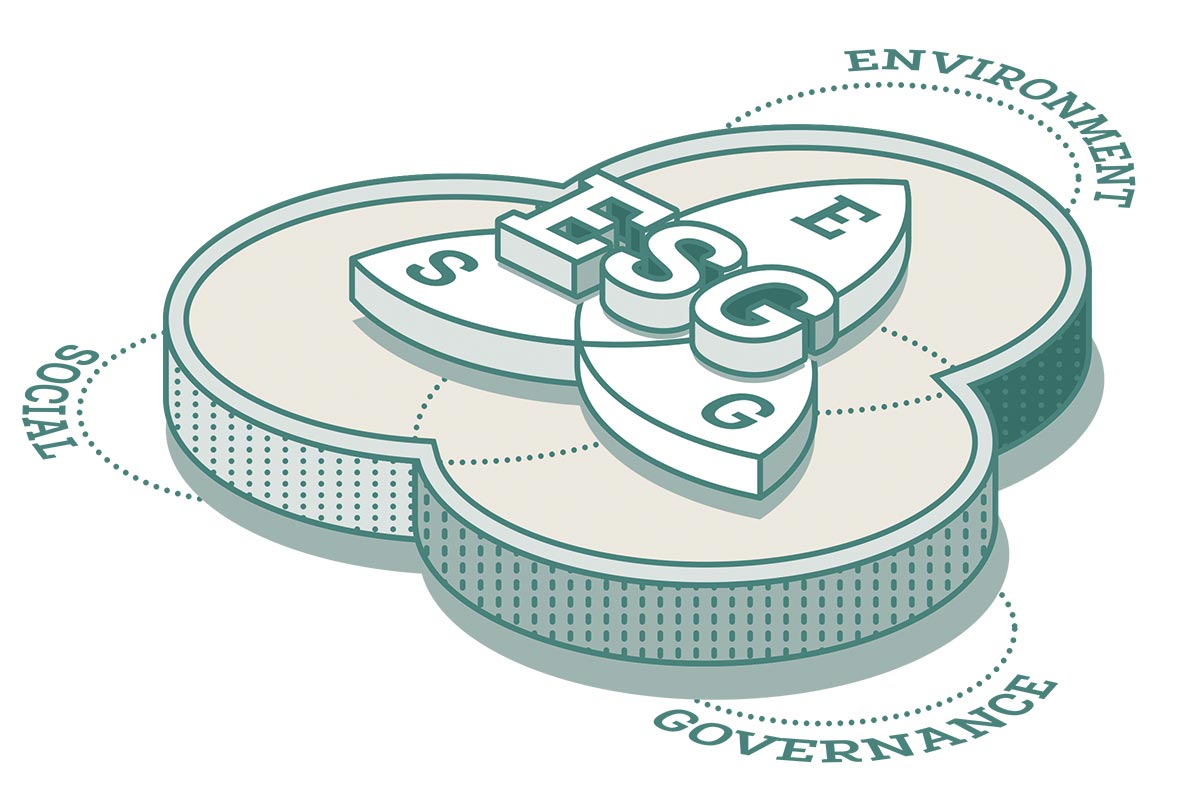
LEGGI ANCHE: Fondi Esg – Cosa sono e quanto rendono
Chevron ed Exxon hanno comprato concorrenti per decine di miliardi di dollari. Il cartello Opec+ sul petrolio continua a farla da padrone, a condizionare le scelte sulla produzione di barili di greggio. Non è un caso che il peso negoziale dell’Arabia Saudita non accenni a diminuire, tanto da aver imposto Riad per l’Expo 2030. D’altronde pesa il costo del denaro: molti investimenti sono stati decisi in tempi in cui i tassi di interesse erano vicini allo zero, il rapido innalzamento ha mandato fuori mercato molti progetti. Il caso della francese Engie è emblematico: sul mercato Usa è stata costretta ad aumentare i prezzi del 50% nella vendita di energia per sopperire alle nuove condizioni di finanziamento.
Tuttavia, la corsa dei fondi Esg non si ferma. Pur mostrando un certo rallentamento. Secondo i dati raccolti da Morningstar, nel terzo trimestre di quest’anno i fondi sostenibili europei hanno fatto registrare flussi netti positivi pari a 15,3 miliardi di dollari. Ed è grazie a questa performance che l’industria del risparmio gestito ha ottenuto un andamento positivo: due terzi della raccolta netta è stata realizzata dagli investimenti che difendono l’ambiente. Va però anche rilevato che nei tre mesi precedenti, aprile-giugno, il saldo era stato positivo per 25,4 miliardi di dollari, dunque una netta decrescita. Nel Vecchio Continente prosegue l’andamento divergente dei fondi cosiddetti “articolo 8” e “articolo 9”, con i primi in calo e i secondi in crescita.
Secondo la normativa comunitaria Sfdr, che regolamenta la sostenibilità nei servizi finanziari, gli articolo 8 dovrebbero “promuovere” le caratteristiche Esg, mentre gli articolo 9 hanno “obiettivi” Esg misurabili. Solo gli articolo 9 sono dunque pienamente Esg ed evitano i sofisticati tentativi di greenwashing su cui l’Europa, con una direttiva ad hoc, sta cercando di porre rimedio. E poi le strozzature sulle catene di fornitura.
2.400 miliardi di dollari – È quanto servirebbe ogni anno per decarbonizzare le economie in via di sviluppo
Alcuni materiali indispensabili alla transizione ecologica sono aumentati di prezzo, ma si fa anche fatica a reperirli. Peccato che da qui al 2030 bisognerebbe apportare aggiustamenti che riducano almeno di un terzo le emissioni. La Cina produce da sola il 33% di CO2, il 12,5% gli Stati Uniti. Pechino ha cominciato a fare sul serio, però così controlla a monte l’intera filiera delle rinnovabili, una leva geopolitica che preoccupa il blocco Usa- Europa. Secondo le stime del think tank finlandese Crea, le rinnovabili installate dalla Repubblica Popolare genereranno nel 2023 oltre 400 Terawattora l’anno, più del fabbisogno della Francia, con 200 Gigawatt di solo solare, il doppio della potenza operativa negli Stati Uniti.
L’altro tema urgente viene segnalato dall’ultimo report dell’Ispi. Riguarda gli investimenti nei Paesi in via di sviluppo: servono entro il 2030 circa 2.400 miliardi l’anno per decarbonizzare queste economie. Soldi che dipendono anche dalle scelte di organismi internazionali come la Banca Mondiale. Sebbene i finanziamenti per il clima forniti ai Paesi emergenti siano aumentati nel 2021 fino a raggiungere 89,6 miliardi di dollari, non sono ancora riusciti a soddisfare l’impegno di 100 miliardi all’anno. Secondo il Fondo monetario internazionale i costi di adattamento al cambiamento climatico raggiungeranno lo 0,25% del Pil globale già nel 2023. I deficit di bilancio in tutto il mondo sono aumentati notevolmente durante la pandemia, poiché i governi hanno agito come “assicuratori di ultima istanza”. Nel 2020 i deficit pubblici sono stati in media superiori al 20% del pil nelle economie avanzate. Di conseguenza, il debito pubblico ha raggiunto nuovi massimi in molti Paesi, con una media superiore al 100% nelle economie mature.
E questo blocca gli investimenti sulla transizione ecologica. Per questo la domanda diventa una: i governi possono permettersi questo tipo di transizione? L’Inflation Reduction Act degli Stati Uniti ha impegnato 391 trilioni di dollari in un decennio. Rispettare questi impegni in un contesto di spazio fiscale limitato e di preoccupazioni sulla sostenibilità del debito pubblico sarà impegnativo. E il 2024, non dimentichiamo, è l’anno delle presidenziali Usa con la probabile sfida tra Trump e Biden. Da chi la spunterà dipenderà la capacità (e le ambizioni) di riduzione delle emissioni. La preoccupazione per la crisi climatica non dovrebbe essere un tema polarizzante, ma negli Usa lo è. Lo scorso anno solo il 22% degli americani che si reputano di destra considerava il cambiamento climatico una grave minaccia. Il divario fra destra e sinistra è molto più ampio di quanto non sia in altri Paesi. Un esempio è il caso dei Repubblicani del Texas, che cercano attivamente di mettere i bastoni fra le ruote alla forte crescita che il settore delle energie rinnovabili sta avendo nel loro Stato.
Questo articolo è stato pubblicato su Business People di gennaio-febbraio 2024. Scarica il numero o abbonati qui
© Riproduzione riservata






