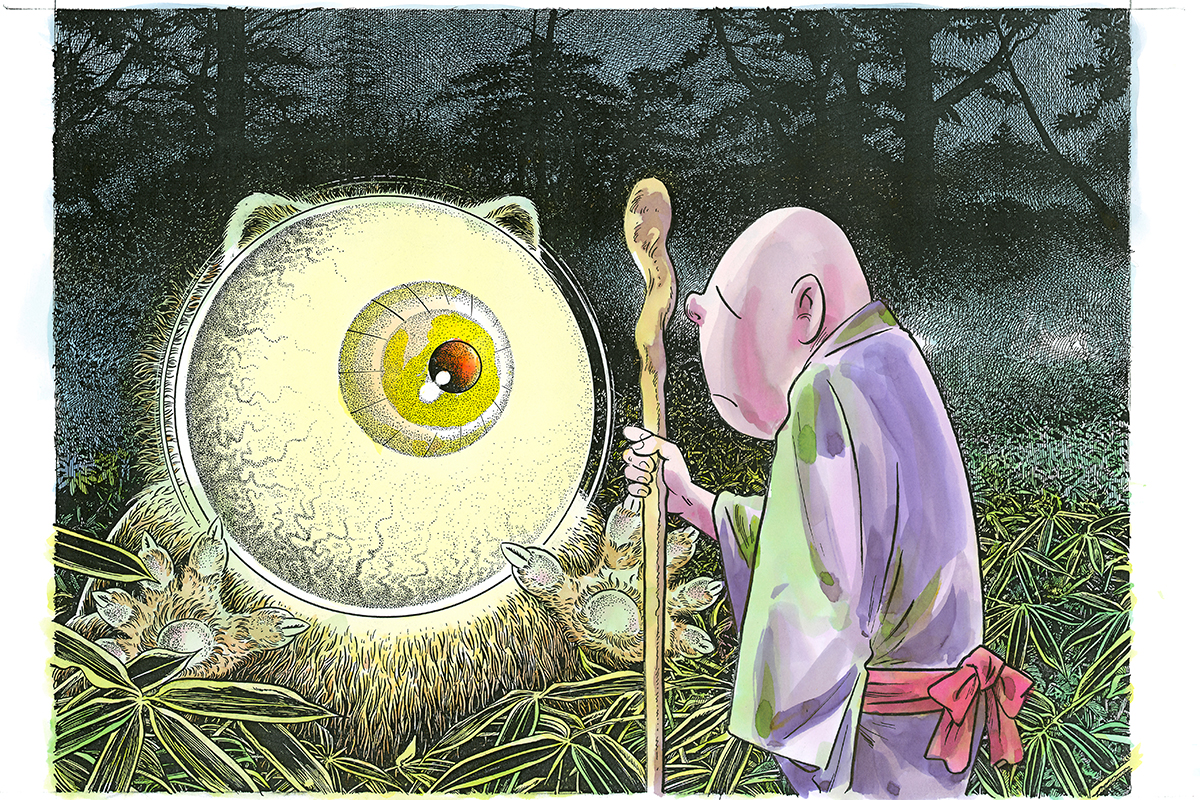I suoi 1.935.901 visitatori – il 3,5% in più rispetto all’anno precedente – gli sono valsi (per l’ennesima volta) anche nel 2014 il titolo di museo più visitato d’Italia. Di cosa stiamo parlando? Della «famosissima Galleria degli Uffizi», come la definisce Dan Brown per bocca del suo alter ego Robert Langdon nel suo ultimo bestseller: Inferno. Persino la teutonica Angela Merkel, in occasione dell’ultimo vertice bilaterale con Matteo Renzi del gennaio scorso, ne ha subito approfittato per una passeggiata lungo il Corridoio vasariano e una visita guidata al museo, per ammirare i suoi celebri capolavori. Eppure questo simbolo di Firenze, sinonimo di arte rinascimentale italiana in tutto il mondo, non è affatto nato per essere un museo. Il palazzo che lo ospita venne infatti costruito, tra il 1560 e il 1580, per volere di Cosimo I de’ Medici con l’obiettivo riunire gli “uffizi” (ossia uffici) delle 13 principali magistrature fiorentine in un’unica sede, posta sotto la sua diretta sorveglianza. A progettare lo splendido edificio, il primo granduca di Toscana chiamò Giorgio Vasari, già al lavoro sul cantiere dell’adiacente Palazzo Vecchio, che disegnò una costruzione con pianta a “U”, organizzata in moduli (ognuno corrispondente a un ufficio, sette sul lato lungo, sei su quello corto) che si ripetono sulle due ali di diversa lunghezza, dalla chiesa di San Pier Scheraggio, inglobata nella costruzione, sino alla Vecchia Zecca. Fu lo stesso Vasari a ideare, nel 1865, anche il celebre Corridoio che porta il suo nome e unisce, attraverso gli Uffizi, Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti, passando su Ponte Vecchio e attraversando la chiesa di Santa Felicita e numerosi edifici adiacenti prima di sbucare nel Giardino di Boboli: un percorso privato che metteva in comunicazione gli appartamenti granducali di Palazzo della Signoria con la nuova residenza della famiglia de’ Medici.
DAI BORDELLI ALLA CULTURACiò che forse non tutti sanno è che uno dei luoghi d’arte e cultura più prestigiosi al mondo, è nato sulle macerie di un antico quartiere popolare a dir poco malfamato, luogo di osterie, bordelli e cadenti case popolari. La zona compresa tra piazza della Signoria e Lungarno, dove oggi sorgono gli Uffizi, ai tempi di Cosimo I era addirittura chiamata “Baldracca”, dal nome di una delle sue bettole più celebri, famosa soprattutto per il giro di prostituzione che vi si teneva. Fu proprio il granduca a far radere al suolo l’intero rione per fare spazio al progetto di Vasari, completato però solo dopo la morte dell’architetto – e dello stesso Cosimo – per opera di un suo altrettanto celebre collega, Bernardo Buontalenti, sotto la guida del colto e raffinato Francesco I de’ Medici. Fu lui, nel 1581, a decidere di adibire la loggia all’ultimo piano dell’edificio a galleria personale dove esporre la sua ampia ed eclettica collezione, che non vantava solo importanti dipinti quattrocenteschi, ma anche medaglie, cammei, statue, armature, miniature, rarità naturalistiche e quant’altro potesse interessare al granduca e alla sua famiglia. E fu sempre lui a far costruire la “Tribuna del Buontalenti”, nucleo centrale della Galleria stessa, l’unica sala nella quale si può ancora realmente comprendere lo spirito originario degli Uffizi, intesi come “luogo di meraviglia”, dove le sculture classiche possano dialogare con i dipinti più significativi. Dopodiché, rendendo questa galleria visitabile su richiesta, diede vita al più antico museo d’Europa. Via via arricchito dai pregevoli acquisti dei suoi successori, che provvidero, almeno in parte, anche ad ampliare le decorazioni e la struttura del palazzo. Quando poi, con la morte di Gian Gastone, si spense la dinastia dei Medici, la sorella di quest’ultimo cedette le opere della famiglia ai Lorena, ma solo a patto che restassero a Firenze e inalienabili. Furono loro ad aprire la Galleria al pubblico nel 1769.
– Intervista al direttore Antonio Natali
DAL ‘300 AL RINASCIMENTOSe poi oggi gli Uffizi sono uno dei musei più famosi al mondo, una ragione c’è: le sue straordinarie collezioni di statue antiche e dipinti. Solo su quest’ultimo fronte, le sue raccolte del ‘300 e del Rinascimento contengono alcuni capolavori assoluti dell’arte di tutti i tempi. Basta ricordare i nomi di Giotto, Simone Martini, Piero della Francesca, Beato Angelico, Filippo Lippi, Botticelli, e poi ancora Mantegna, Correggio, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio. E molti altri ancora. Inoltre le “superstar” della Galleria contano anche pittori tedeschi, olandesi e fiamminghi, tra cui Dürer, Rembrandt e Rubens. In più, oltre alle opere ospitate dal già citato Corridoio vasariano (dipinti del ‘600 e autoritratti), nel complesso trovano spazio anche altre importanti raccolte: la Collezione Contini Bonacossi e il Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.
LAVORI IN CORSOMa tutto questo non basta. Ormai dal 2010 è in corso un monumentale progetto di rinnovamento, detto dei “Nuovi Uffizi”, che prevede il raddoppio della capacità espositiva del museo attraverso il restauro e l’adeguamento funzionale degli ambienti che compongono l’intero complesso. L’intervento di maggiore rilevanza (ma non l’unico) è il recupero delle sale del piano nobile, occupate fino alla fine degli anni ‘70 dagli scaffali dell’Archivio di Stato di Firenze, riconvertite in una lunga infilata completamente dedicata alle funzioni espositive, che è andata così ad aggiungersi alla superficie della Galleria del secondo piano. A rendere unico il progetto, le modalità di avanzamento dei lavori: benché di enorme rilevanza, il cantiere viene portato avanti anno dopo anno garantendo sempre e comunque l’apertura del museo e senza ridurre la programmazione annuale di mostre temporanee. Un grande progetto che ha permesso anche a un’importante scoperta archeologica: un vasto cimitero di tarda età romana, con una sessantina di scheletri, è stato rinvenuto durante i lavori nell’area sottostante il salone di lettura della Biblioteca Magliabechiana. Un luogo di sepoltura nato probabilmente in occasione di un’epidemia, che portò alla morte di un gran numero di abitanti della Firenze della tarda antichità e del primo alto Medioevo.
© Riproduzione riservata