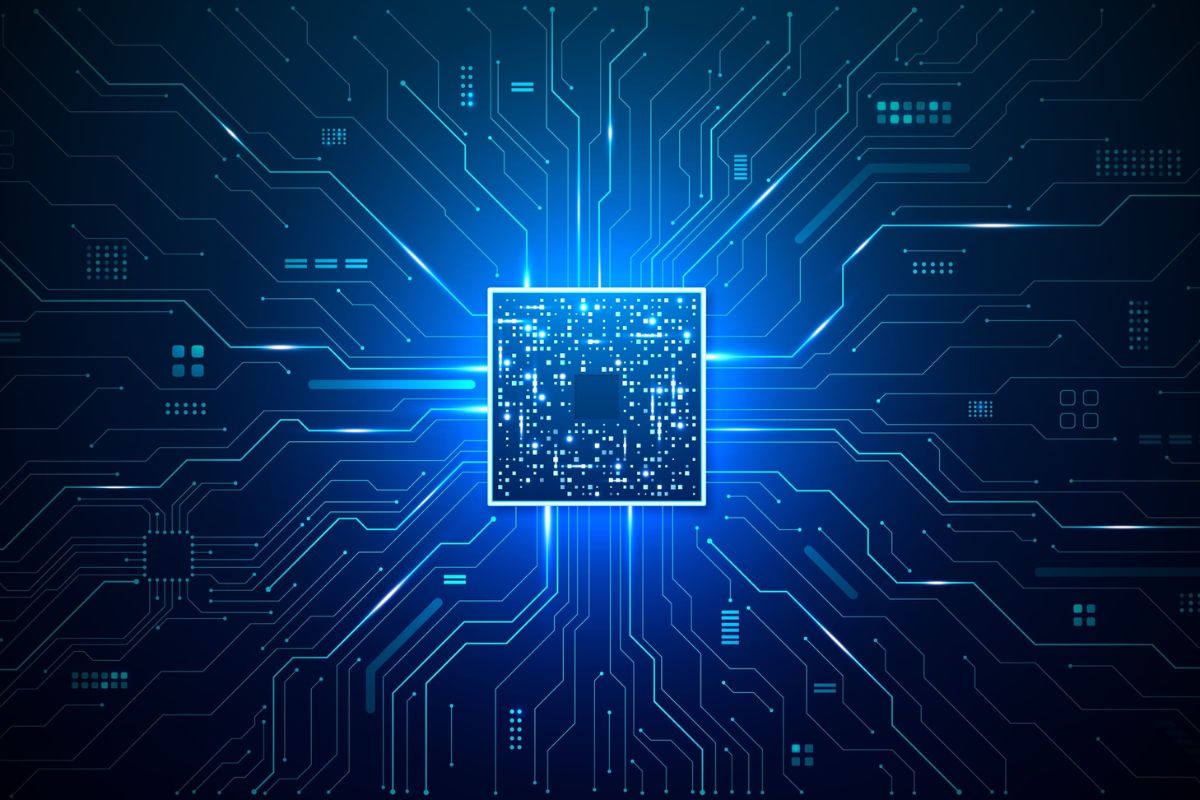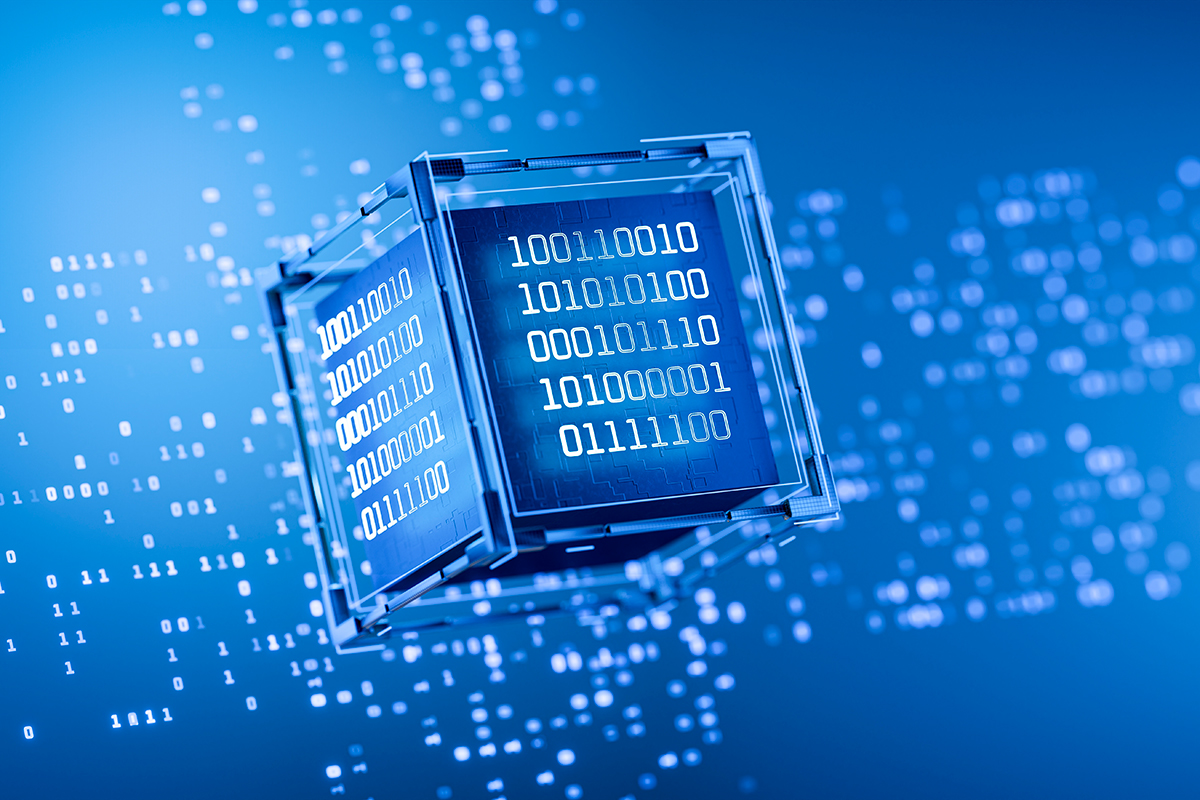Sarà cinico chiederselo, ma la domanda bisogna per forza farsela. Chi è che ci perde con la fine (annunciata) della guerra in Iraq? Prima risposta: quella miriade di società che gravitano attorno al Pentagono, con il quale hanno firmato lucrosissimi contratti di fornitura. E la prima “fornitura” che il Pentagono ha richiesto ai privati è quella di personale addestrato a operare in zona di guerra.Ora per queste società iniziano i guai. Lo avevano intuito già l’anno scorso, quando in campagna elettorale Barack Obama aveva promesso il ritiro delle truppe Usa. Ne hanno avuto la certezza dopo la sua elezione alla presidenza degli Stati Uniti. A febbraio, in un discorso davanti ai marine di Camp Lejeune, in Carolina del Nord, Obama ha infatti annunciato il ritiro delle forze armate Usa entro la fine del 2011, dopo quasi sei anni di permanenza (ognuno dei quali è costato, come minimo 100 miliardi di dollari l’anno, tutti fondi che verranno meno alla rete di imprese che hanno sostenuto lo sforzo bellico oltre che quello della ricostruzione delle infrastrutture civili). Alla base della svolta “pacifista” di Obama ci sono anche solide motivazioni economiche. Dagli attuali 142 mila soldati si scenderà al massimo a 50 mila (altrettanti resteranno in Afghanistan).
Chi guadagna?A perderci, alla fine, saranno le aziende private che hanno investito nel business della guerra: quelle americane sono il 90%, ingaggiate, incoraggiate o affiancate dal governo. A cominciare, appunto, dai cosiddetti contractor, cioè le società appaltatrici che svolgono lavori e forniscono servizi su commissione dell’amministrazione. Attualmente i contactor sono arrivati a 190 mila, più dei 160 mila soldati americani impegnati in Iraq. Per la maggior parte sono società americane, ma ci sono anche iracheni e operatori di altri Paesi. Non si tratta solo di 007 privati o di soldati mercenari; svolgono più in generale attività di supporto alle truppe, dalle mense, alla costruzione di impianti, all’appoggio logistico, fino alle funzioni di intelligence e security e alle operazioni militari vere e proprie. Secondo stime, il 20% dei soldi spesi dagli Stati Uniti per il conflitto in Iraq dal 2003 al 2007 è finito proprio nelle casse dei contractor: 83 miliardi di dollari, secondo quanto affermato dal Congressional budget office, l’Ufficio per il bilancio del Parlamento americano. E nel 2008 le spese di ingaggio hanno toccato i 100 miliardi di dollari; mai prima il Dipartimento della difesa aveva privatizzato una quota così grande dei servizi per le forze armate. Ad agosto 2008 la spesa totale dell’intervento era arrivato a toccare i 446 miliardi, di cui appunto quasi 100 sono andati ai privati, il 70% in Iraq e il 30% per contratti relativi a Paesi vicini come Kuwait, Arabia Saudita e Qatar. Una tale massa di denaro non poteva non far esplodere casi molto oscuri, come quello che è andato sotto il nome di Blackwater. Un episodio che innescò l’inizio di un’inversione di tendenza. A gennaio il generale Raymond Odierno, comandante in capo delle forze Usa, ha emesso una direttiva che ordina alle unità militari di iniziare a ridurre il numero dei contractor, statunitensi e non, del 5% ogni trimestre, assumendo al loro posto personale iracheno. Dal primo gennaio inoltre il cosiddetto «Accordo di sicurezza» tra Stati Uniti e Iraq ha tolto l’immunità alle società appaltatrici nei confronti della legge locale. Presto dunque l’era dei contractor si chiuderà e chi vorrà fare affari in Iraq dovrà prendere altre strade. Di recente a Londra la conferenza Invest Iraq ha mostrato il potenziale dell’economia irachena e le opportunità per gli investimenti, ma anche gli ostacoli e le difficoltà da superare.L’Iraqi National Investment Commission indica i settori di affari più promettenti: energia, telecomunicazioni, trasporti oltre all’edilizia residenziale, dato che il Paese avrà bisogno di più di 3,5 milioni di case nei prossimi dieci anni. L’Iraq Investment and Reconstruction Task Force (Iirtf) dello Us Department of Commerce inoltre lavora a stretto contatto con l’ambasciata Usa in Iraq per dare informazioni e supporto alle aziende, oltre ai consigli sulle business opportunity legate ai contratti e subcontratti per la ricostruzione, alle possibilità di stipulare accordi con i ministeri iracheni, il settore privato e con l’Onu e le altre organizzazioni internazionali.
Dove investireL’appello agli investimenti stranieri e al rafforzamento del settore privato da parte dell’Iraq si è intensificato dopo che il crollo dei prezzi del petrolio ha costretto il Governo a tagliare il suo budget complessivo di quasi un quarto, fino a circa 60 miliardi di dollari. L’Iraq non è ancora in grado di finanziare la propria ricostruzione, per soddisfare le esigenze fondamentali della popolazione al Paese servono investimenti per almeno 400 miliardi di dollari. Le infrastrutture locali sono inadeguate e Baghdad è costretta a importare i derivati del petrolio da Iran, Kuwait e Turchia. Un paradosso, visto che il Paese ha riserve di petrolio per 119 miliardi di barili. Manca, infatti, ancora una legge che regoli definitivamente l’accesso delle società esterne al petrolio locale e che suddivida le risorse tra le diverse province irachene. Prima della guerra le importazioni di petrolio da Baghdad negli Usa erano alle stelle, tuttavia le multinazionali americane non hanno mai potuto violare il sottosuolo iracheno, né godevano di condizioni vantaggiose. Ora le cose sono radicalmente cambiate. Nel 2007 Baghdad ha varato un disegno di legge sugli idrocarburi secondo il quale le compagnie straniere possono per la prima volta controllare il petrolio iracheno. Grazie a contratti di lungo termine possono acquisire diritti esclusivi, ma i guadagni devono essere suddivisi tra privato e Stato iracheno. Inoltre il disegno di legge stabilisce un’imposta sul reddito del 35% per le società petrolifere estere che lavoreranno in Iraq. In attesa che le normative comincino a disegnare la nuova struttura economica del Paese le compagnie statunitensi hanno già individuato nel Kurdistan iracheno la regione trainante per l’economia e quindi la porta principale da cui accedere al restante territorio. L’area semi-indipendente nel Nord del Paese offre infatti grosse opportunità e sta avendo un rapido sviluppo, con una crescita del Pil del 10% l’anno, meglio di Cina e India. La regione ha bisogno soprattutto di infrastrutture, attrezzature e know how per il raffinamento del petrolio e per l’energia elettrica. Negli ultimi mesi inoltre c’è stato un boom nella ricostruzione e nella vendita al dettaglio. La regione è ricca di petrolio ma anche di acqua, l’agricoltura è sviluppata e gli interessi sia privati sia governativi non mancano. Non è un caso se i cinesi fanno affari in Kurdistan fin dai primi anni Novanta.
© Riproduzione riservata