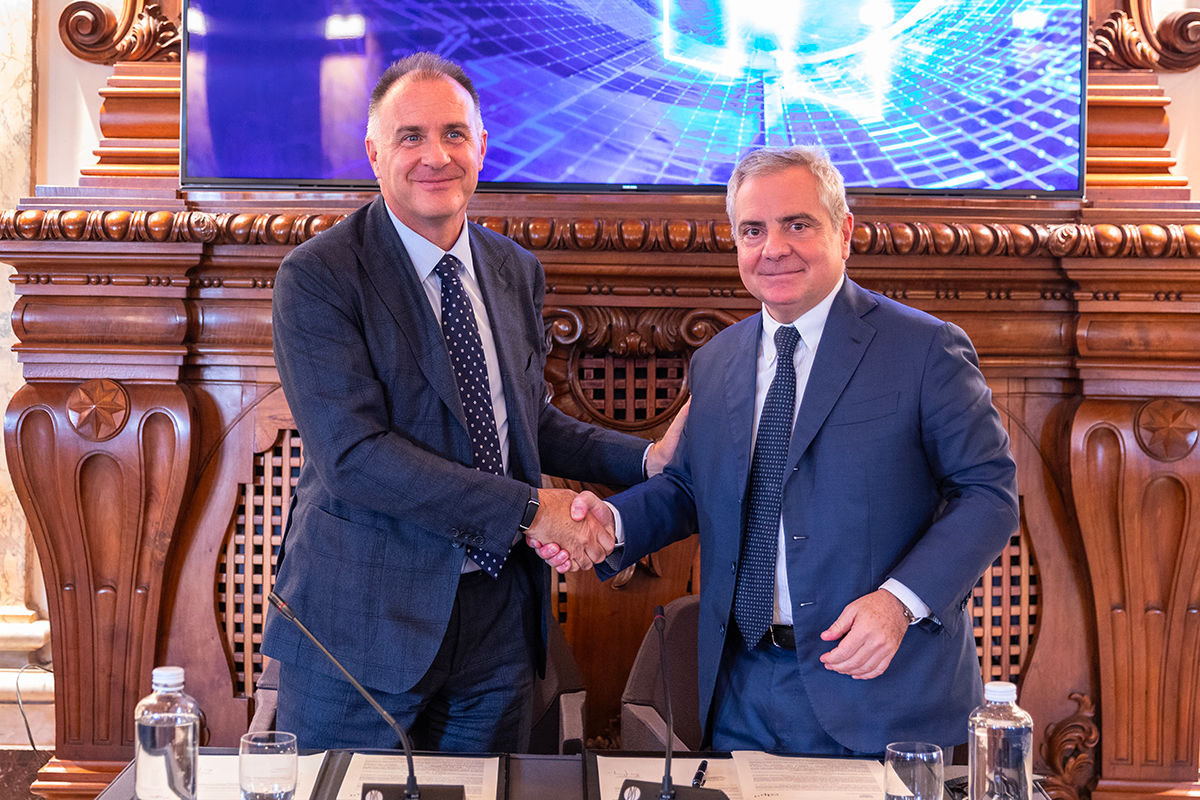E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così!». Forse Fred Buscaglione questa canzone l’ha scritta pensando all’impresa italiana tipo, che è davvero piccola così, tanto che se si consultano le ultime rilevazioni Istat si resta sorpresi: delle 4.390.911 aziende che risultavano attive nel 2016, ben 4.180.780 erano micro, cioè avevano meno di dieci dipendenti e un fatturato inferiore ai due milioni di euro l’anno. Quelle grandi, cioè con più di 250 dipendenti e un fatturato superiore ai 50 milioni, erano 3.787. Piccolo è bello, quindi? La risposta a questa domanda varia a seconda della congiuntura. In questo momento particolare, le aziende formato puffo non suscitano molta simpatia. E infatti la canzone oggi proseguirebbe così: «T’ho viziata, coccolata ma tu non ti sei quotata». E certo, come fanno a trovare spazio in Borsa delle aziende che entrano in una borsetta? Queste, per raccogliere i capitali necessari alla crescita, non possono far altro che rivolgersi alle banche, sviluppando una dipendenza che genera un altro male italiano: il bancocentrismo (Dante ci perdoni).
Avere un solo canale finanziario di crescita condanna l’impresa italiana al nanismo, soprattutto in un periodo in cui le banche prestano poco volentieri. Questa interpretazione che convince molti, fa storcere il naso a diversi esperti del settore. Per esempio, a Fabio Troiani, Ceo di BIP – Business Integration Partners, multinazionale italiana della consulenza aziendale, che spiega quali sono i punti cardine di una strategia di crescita: «Se parliamo di risorse, è chiaro che i canali tradizionali soffrono di un problema regolatorio e di miopie interne che fanno sì che, almeno presso la classica banca medio-grande, questo tipo di aziende sia abbastanza negletto. Però bisogna aggiungere che si stanno gradualmente affermando diverse istituzioni finanziarie parallele, dai fondi di debito a quelli di private equity, dal crowdfunding al peer to peer lending, le quali, con rendimenti più che discreti, mettono a disposizione di organizzazioni molto snelle quella liquidità che serve a queste ultime per passare alla fase successiva di crescita. Questo dimostra che quello del finanziamento è un falso problema. Di fatto, la banca di oggi è stata disintermediata».
Una delle prime cose che allora gli imprenditori dovrebbero fare, secondo il manager, è un corso di Fintech o di nuova finanza, per avere chiaro quale sia il ventaglio di opportunità alternative al canale bancario. Ma poi i nodi vengono al pettine perché, una volta che l’impresa ha i capitali, deve usarli, cioè deve avere dei piani di sviluppo e qui la parola chiave è “digitalizzazione”. «La trasformazione digitale», spiega Troiani, «di solito produce un duplice impatto. In primo luogo, garantisce scalabilità, cioè permette di scalare l’attività molto più facilmente, ma soprattutto consente all’impresa di passare da un business di prodotto a uno di servizio, che è un qualcosa che si mantiene nel tempo e garantisce flussi di cassa più stabili». Questa è la chiave di volta. «Per raggiungere nuovi mercati o semplificare e snellire il processo produttivo, le aziende devono aprirsi a canali digitali o potenziare la tecnologia disponibile per aumentare la propria forza di vendita. Questo è ormai un trend abbastanza consolidato. Chi lo ha saputo fare, è riuscito a esportare i propri prodotti dalla piccola provincia italiana a mercati mondiali come quello cinese e americano, senza dover essere fisicamente presente in loco», riassume l’a.d..
Sembra facile ma occorre un buon capitale, finanziario ma soprattutto umano, su questo il consulente non ha dubbi: «È ovvio che i canali digitali devono essere fatti con tutti i crismi, e quindi c’è bisogno di un investimento adeguato. Per essere chiari, per mettere in piedi un e-commerce che funzioni non basta dotarsi solo di un’interfaccia, ma è necessario costruire una catena di tecnologie che supportino non solo la vendita ma anche la logistica, l’after sale e così via». Va detto che non si tratta nemmeno di una spesa troppo ingente: «Oggi ci sono cose come il software as a service oppure il cloud on demand. Questo fa sì che quelli che una volta erano investimenti ingenti, Capex in gergo, oggi siano delle spese operative, Opex, meno onerose e in qualche modo legate al tipo di attività. È tutto commisurato al risultato, quindi anche il rischio di impresa diventa più basso», assicura il consulente.

Insomma, il capitale disponibile c’è, la tecnologia non ha costi proibitivi, allora cosa manca? Spesso audacia, mentalità e soprattutto una forte motivazione, che è il primo ingrediente per fare della buona R&D. Il caso Fca, costretta a cercare l’abbraccio con Renault (leggi Nissan) per recuperare un ritardo tecnologico grave, conferma che alle pmi mancano i capitali ma alle grandi spesso manca una vision, che non sia la banale furbizia di chi vende i gioielli di casa, come Magneti Marelli, per distribuire lauti dividendi agli azionisti. Per crescere non bastano quindi i soldi, ci vuole una visione e servono delle competenze: «È necessaria la capacità di sviluppare talenti che sappiano utilizzare queste tecnologie e avere quindi a disposizione le competenze giuste, interne all’azienda o attraverso il supporto di società di consulenza». Ma anche questo non è scontato.
Chi riesce a costruirsi un canale digitale efficiente, può allargare il suo bacino di utenza, anche una semplice pizzeria che decida di lavorare con Deliveroo o Foodora. «Per questo tutti i grandi fondi di private equity stanno investendo in aziende italiane di piccole dimensioni che operano in quei campi in cui il made in Italy è un’eccellenza. Rilevano imprese ad altissima potenzialità da imprenditori pronti a vendere e, con un investimento limitato, possono fare un revamping e trasformarle in ottime opportunità», conclude il manager. È vero che questi fondi hanno una visione del business diversa da quella che può avere un imprenditore, il quale ragiona su scale temporali diverse e tende a essere un po’ più sedentario di investitori che, spesso, si comportano come locuste. Però si resta col dubbio che, con tante lodevoli eccezioni, le imprese italiane siano piccole perché non sono abbastanza grandi le lenti di chi guarda al futuro.
© Riproduzione riservata