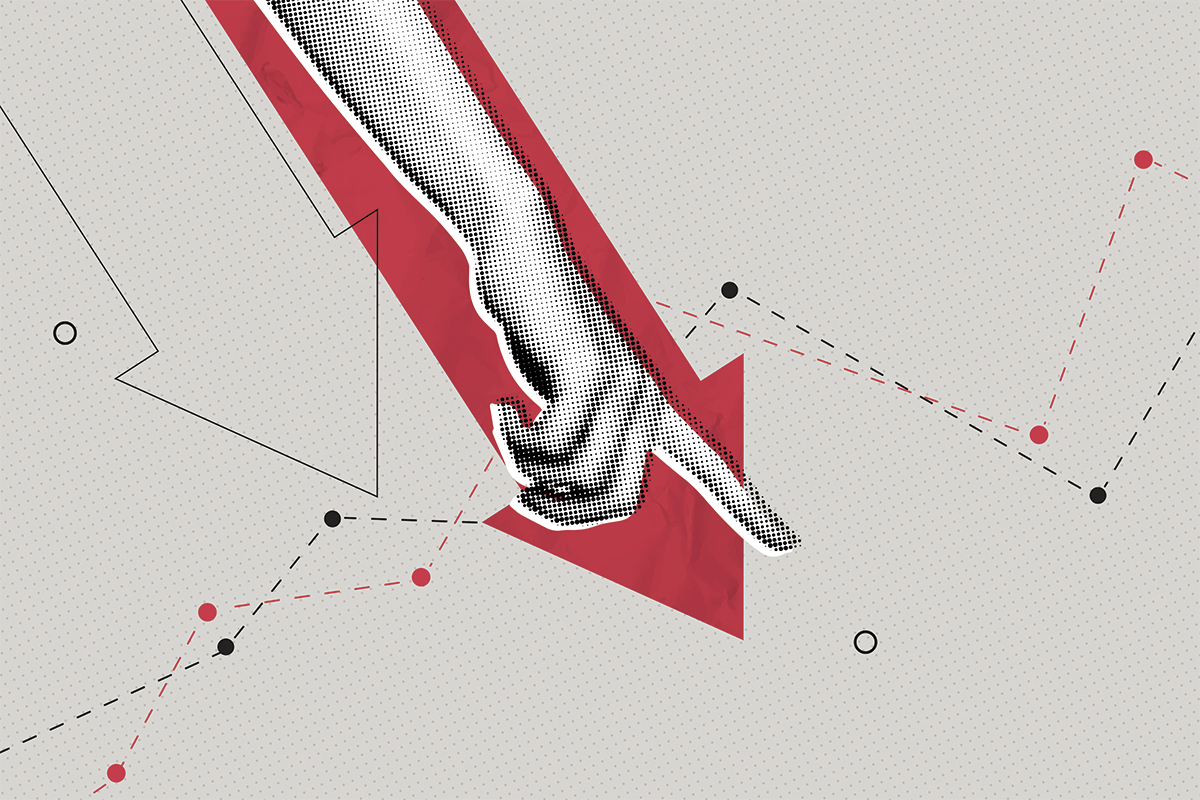Nome in codice: SelectUsa. Esiste dai tempi di Barack Obama ma ora sta trovando nuova linfa. È un progetto su larga scala costruito da ormai diverse amministrazioni americane, due a guida democratica e ora supportato dai conservatori, per incentivare gli insediamenti di aziende straniere negli Usa. Trump lo ha notato ed è perfettamente compatibile con la sua politica commerciale aggressiva che mette al centro l’America First, prima gli Stati Uniti e poi il resto, con l’obiettivo dichiarato di riportare la manifattura sul suolo americano contrastando la Cina fabbrica del mondo.
Lo scorso marzo si sono già tenuti una serie di incontri in tutt’Italia, tra i principali a Treviso, Bologna, Milano e Napoli. Da un lato un nutrito gruppo di imprenditori nostrani spaventati da quello che sta avvenendo con la minaccia di dazi che pende come una spada di Damocle sui loro modelli di business. Dall’altra rappresentanti delle organizzazioni per lo sviluppo economico dei diversi Stati a stelle e strisce a incensare la politica di accoglienza della madrepatria che aspetta solo nuovi e diretti investimenti dall’estero. Inevitabile il supporto di AmCham, la Camera di commercio americana in Italia, che si è prodigata in questi mesi per fornire una via d’uscita a chi teme di rimanere schiacciato dalle tariffe americane anche in presenza di un accordo tra Usa e Ue. Il gran finale di questo ammiccamento tra i due Paesi ha avuto luogo dall’11 al 14 maggio, con gli imprenditori italiani invitati a Washington per capire meglio come aprire impianti da quelle parti.
Dazi Usa: Italia tra i Paesi più esposti
Sono stati fatti confronti per capire quale è il contesto più vantaggioso per impiantare la propria impresa. Presenti tutti gli Stati, dall’Alabama al Wisconsin. Di fatto in concorrenza tra loro nell’offerta di incentivi, dalla formazione del personale, al taglio delle tasse per i primi anni, fino ai contributi a fondo perduto. Confindustria ammette senza remore che «il rischio è la fuga di aziende e capitali negli Usa». Il presidente Emanuele Orsini ha lanciato l’allarme sui dazi: insieme alla svalutazione del dollaro, comporterebbero un impatto reale del +23,5% sui prezzi dei prodotti italiani, con una perdita stimata di 20 miliardi di export e 118 mila posti di lavoro entro il 2026.
Non si tratta solo di beni di lusso, ma anche di settori sensibili al prezzo come macchinari, mezzi di trasporto e pelletteria. Per questo, avverte, considerarli “sostenibili” sarebbe un grave errore: il contraccolpo sull’industria italiana sarebbe pesantissimo. D’altronde l’Italia è tra i Paesi più esposti, considerando che il 22,2% delle sue esportazioni extra-Ue è destinato proprio agli Stati Uniti. È inevitabile che si stia per assistere a una riduzione delle esportazioni a causa dell’aumento dei prezzi finali per i consumatori americani. La conseguenza può essere la perdita di quote di mercato, a favore di concorrenti non colpiti dai dazi.
A rendere il quadro ancora più complesso è la questione delle piccole e medie imprese, che rappresentano l’ossatura del sistema produttivo italiano. Molte di queste non hanno la capacità finanziaria per assorbire i costi aggiuntivi dei dazi o per trasferire rapidamente la produzione in territorio americano, come invece potrebbero fare le grandi multinazionali. Ciò sta già creando molta incertezza per le aziende, spingendole a posticipare gli investimenti. Questo rappresenta un ulteriore ostacolo alla crescita economica.

Illustrazione generata con intelligenza artificiale tramite ChatGpt/Dall·E (OpenAI)
Delocalizzare negli Stati Uniti: i costi per le imprese
Delocalizzare negli Stati Uniti, però, non significa semplicemente cambiare etichetta o spedire container. Significa comprare terreni, edificare stabilimenti, trovare manodopera locale, ottenere autorizzazioni, garantire continuità nella qualità e nei tempi di produzione. Tutto questo mentre l’inflazione americana spinge verso l’alto il costo della vita e delle attività produttive, e mentre il dollaro continua a muoversi con forti oscillazioni rispetto all’euro. Secondo un recente studio della Confindustria Usa-Italia, per aprire un sito produttivo negli Stati Uniti servono in media dai 12 ai 24 mesi e un investimento iniziale che può oscillare tra i 5 e i 15 milioni di euro. Una cifra che non tutte le imprese possono sostenere, soprattutto senza garanzie stabili di lungo periodo. Il presidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, ha spiegato che «un nostro team ha avviato discussioni per aumentare la nostra capacità produttiva negli Usa».
«Stiamo facendo un lavoro di valutazione per capire se una parte di quanto vendiamo sul mercato statunitense può essere prodotto lì, negli Stati Uniti», ha ammesso l’amministratrice delegata di Illycaffè Cristina Scocchia. Aggiungendo di sperare «che non sia necessario», invitando anche a ragionare sul rischio di aumento del costo del lavoro: «Gli Stati Uniti sono un Paese con bassa disoccupazione e alta occupazione e le recenti politiche migratorie di Trump sono restrittive. Sembra quindi difficile che molte aziende europee possano trasferirsi senza creare dinamiche inflattive sui salari».
Dunque, anche il caffè italiano è nel mirino della geopolitica. Se i dazi promessi da Donald Trump dovessero estendersi anche al caffè, Illy potrebbe essere costretta a rivedere il proprio assetto industriale, valutando lo spostamento di parte della produzione negli Stati Uniti. Uno scenario ipotetico, ma tutt’altro che remoto.
Prysmian, dal canto suo, ha approvato un investimento di circa 245 milioni in Nord America per potenziare la produzione di cavi di media tensione. Il gruppo dell’alimentare Granarolo intende ampliare lo stabilimento nel Connecticut e raddoppiare la produzione. Stesso discorso per Lavazza, che ha reso noto di voler accelerare gli investimenti a Philadelfia. Durante l’assemblea degli azionisti a Parigi del gruppo italo-francese EssilorLuxottica, l’amministratore delegato Francesco Milleri ha dichiarato che la società sta valutando la possibilità di aumentare la produzione negli Stati Uniti. «Attenderemo tre-quattro mesi per avere una situazione più stabile prima di decidere», ha spiegato Milleri, riferendosi al contesto incerto dei dazi commerciali. Il direttore finanziario Stefano Grassi ha confermato la prudenza davanti a uno scenario mutevole, segnalando che tra le misure in esame ci sono anche lievi aggiustamenti di prezzo sul mercato americano.

Illustrazione generata con intelligenza artificiale tramite ChatGpt/Dall·E (OpenAI)
Intanto, il colosso francese Hermès, per difendersi dalle minacce tariffarie della Casa Bianca, ha appena alzato i prezzi negli Stati Uniti con incrementi compresi tra il 4% e il 5%, una strategia mirata a compensare i dazi all’importazione. I rincari hanno riguardato in particolare le categorie principali – pelletteria, prêt-à-porter, seta e gioielleria – che rappresentano più del 90% dei ricavi del brand. L’obiettivo è duplice: proteggere i margini da eventuali dazi fino al 20% e mitigare l’effetto della debolezza del dollaro rispetto all’euro.
Anche Louis Vuitton ha attuato adeguamenti dei listini, pur mantenendo inalterati i prezzi di molti articoli, una scelta possibile grazie alla presenza di tre siti negli Usa. Prada aspetta: l’amministratore delegato Andrea Guerra spiega che eventuali decisioni sul pricing saranno prese in base all’evoluzione della politica commerciale americana.
Stessa decisione per Ferrari che ha deciso un aumento dei prezzi fino al 10%. Secondo gli analisti, i clienti statunitensi della Ferrari non saranno scoraggiati dai prezzi più alti. Non ha ancora stabilito cosa fare Stellantis, che dall’Italia esporta in Usa modelli come la 500 elettrica, l’Alfa Giulia, Tonale e Stelvio. Numeri comunque contenuti sui quali l’azienda aspetta di fare le sue valutazioni quando le misure saranno più chiare. Per ora, l’unica decisione presa quella di sospendere la fabbricazione della Dodge Hornet, a partire dal 2026, nello stabilimento italiano di Pomigliano d’Arco.
Infine, Otb (gruppo italiano che controlla Diesel, Jil Sander e Maison Margiela) sta eseguendo simulazioni per valutare aumenti tra l’8% e il 9% sul mercato statunitense. «Stiamo analizzando, marchio per marchio, le possibili azioni per ridurre l’impatto delle tariffe», dice il Ceo Ubaldo Minelli.
Il conto lo pagano anche le famiglie

Illustrazione generata con intelligenza artificiale tramite ChatGpt/Dall·E (OpenAI)
Le tariffe Usa al 15% verso le importazioni di prodotti europei rischiano di far crollare anche la spesa delle famiglie italiane, con un possibile effetto domino sull’economia. L’ipotesi viene rilanciata da Nino Gronchi, presidente di Confesercenti, che segnala come i dazi possono avere anche un contraccolpo sui consumi nazionali. «Pur colpendo principalmente le esportazioni, i dazi avranno ricadute significative anche sul mercato interno: il rallentamento della crescita globale e i possibili effetti che avrebbe sull’occupazione italiana rischiano di riflettersi negativamente pure sui consumi», spiega il numero uno dell’associazione di negozianti al dettaglio.
Assieme a Cer (Centro Europa ricerche), Confesercenti stima una riduzione della spesa delle famiglie vicina ai 12 miliardi in due anni: -2,1 nel 2025 e -9,8 l’anno prossimo. Gronchi, dunque, invita a non considerare solo i rischi per l’industria e il settore agro-alimentare. «Tutto il mondo del terziario potrebbe essere coinvolto e anche il comparto turistico sta risentendo di questa politica di annunci, al punto tale che, dopo un avvio d’anno in crescita per i flussi di visitatori americani, a giugno si è registrata un’inversione di tendenza, con una riduzione che, secondo le nostre stime, ha toccato 193 mila presenze in meno nel nostro Paese rispetto allo scorso anno». E aggiunge: l’Italia e l’Unione europea devono «trattare fino all’ultimo momento» per evitare la guerra commerciale.
Questo articolo è stato pubblicato su Business People di settembre 2025, scarica il numero o abbonati qui
© Riproduzione riservata
 Illustrazione generata con intelligenza artificiale tramite ChatGpt/Dall·E (OpenAI)
Illustrazione generata con intelligenza artificiale tramite ChatGpt/Dall·E (OpenAI)