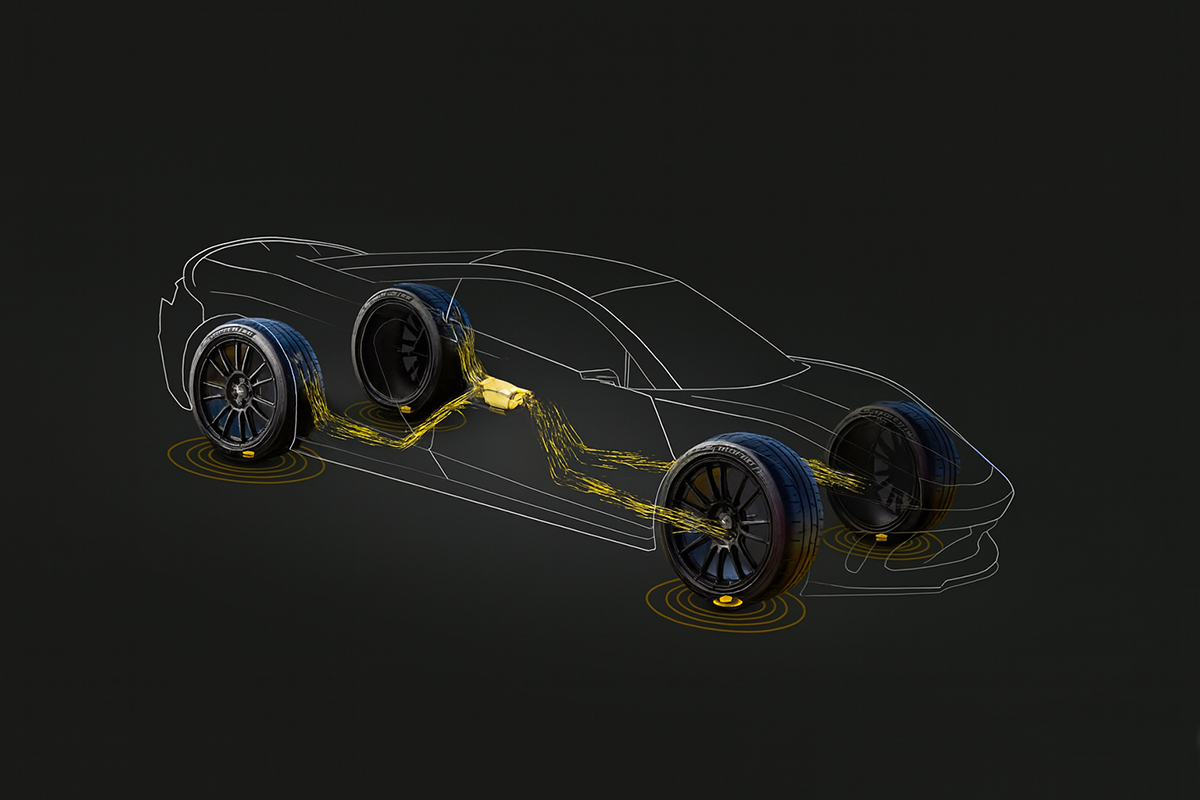C’è un “quadrilatero” in centro a Milano che attira ogni anno milioni di turisti. E non è quello della Moda. Il Museo del Novecento e quello del Duomo, poi la Scala, le Gallerie d’Italia e il Poldi Pezzoli disegnano sulla mappa un’area pedonale così vasta e ricca d’arte da fare impallidire la famosa “isola dei musei” di Berlino. Il fulcro di tutto è Brera, con la Pinacoteca e l’Accademia, l’Orto botanico e l’Osservatorio astronomico. E il suo primato è di quelli difficili da battere: l’istituzione milanese, caso raro in Italia, attira ogni anno centinaia di studenti stranieri, tutti in coda per entrare in una delle più prestigiose scuole d’arte. Per dirla coi numeri, in queste aule studiano (e creano) 4 mila ragazzi, un terzo dei quali sono stranieri. Vengono soprattutto dalla Cina – sono centinaia le nuove matricole a ogni anno accademico, per un totale di quasi 500 iscritti – e dall’Iran. E il trend non accenna a diminuire. Cosa attira così tanti (futuri) artisti da tutto il mondo? Semplice: Brera è un sistema complesso e articolato, ma che funziona. E bene. «Siamo stati i primi in Italia», ci spiega il direttore Franco Marrocco, «ad avere tentato, con successo, di cambiare il modo in cui da sempre si insegnano le belle arti e le materie umanistiche. «Siamo una scuola del fare nel senso più nobile del termine e usiamo questo approccio per tutte le materie: così, mentre nessuno si stupisce all’idea di un laboratorio di pittura, in pochi capiscono l’innovazione di un laboratorio umanistico come il nostro». Già, che significa? «Il laboratorio teorico è la nostra chiave vincente rispetto all’offerta di altre facoltà: è qui dentro che avviene la genesi del pensiero, la formazione delle idee, la concezione del progetto e infine la produzione. Vale per un dipinto o una scultura, così come per qualsiasi altra materia, anche più teorica». Così Brera è diventata il modello da copiare: e se americani o cinesi vogliono provarci, possono (devono?) chiedere a Marrocco come si fa. «Sono andato a San Pietroburgo per un confronto internazionale con i direttori delle università dell’arte più importanti al mondo, dalla Cina all’America, portando la tesi che le discipline, tutte, vanno vissute e spiegate come un grande laboratorio». Ma c’è di più. Il modello Brera potrebbe essere il nuovo paradigma anche per i sistemi aziendali. Marrocco lo sa bene, lui che spesso è entrato negli uffici per parlare a quei manager che forse non sono mai stati davanti a un cavalletto ma tutti i giorni parlano di formazione (professionale), prospettive (di carriera) e traiettorie (di marketing), usando le stesse parole con le quali Leonardo da Vinci descriveva i suoi studi sulla prospettiva (del paesaggio), Canova la “formatura” (delle statue in gesso) e i Futuristi le traiettorie (delle linee in movimento).Brera, come tante altre accademie in Italia – Urbino per la grafica o Carrara per la scultura solo per citarne alcune – sta guidando la rinascita di queste scuole e punta in alto. «La riforma non sarà completa finché non vedremo il titolo di studio e lo stato giuridico dei professori parificato a quello delle università», guarda avanti il direttore. Nel frattempo il sistema Brera dimostra di cavarsela benissimo, anche con pochi fondi («viviamo di rette») e poca autonomia economica. Ci riesce l’Accademia, ci riesce la Pinacoteca, una delle più ricche collezioni di capolavori al mondo, con una storia millenaria. L’edificio che vediamo oggi, infatti – e che da domani probabilmente non vedremo più, perché il progetto della Grande Brera è partito e presto cambierà tutto – risale al 1171, quando i monaci dell’ordine degli Umiliati scelsero quest’area, ai margini della città, come loro sede. Vengono poi cacciati nel 1573 dal Cardinal Borromeo per far spazio ai Gesuiti: i lavori di costruzione del loro collegio terminano nel 1627, ma le scuole non fanno in tempo ad aprire che arriva la grande peste. Nel 1773 anche i Gesuiti devono lasciare e il collegio viene trasformato in una scuola laica: all’Osservatorio astronomico si aggiungono una grande biblioteca, l’Orto botanico (1774) e la prestigiosa Accademia di belle arti, appena due anni dopo (1776). Con l’Accademia nasce anche il primo embrione della Pinacoteca, anche se il vero inizio si deve a Napoleone e all’Editto del 1805 con il quale l’imperatore decide di raccogliere capolavori in giro per l’Italia e portarli qui a Milano. Si parte alla grande con la Predica di san Marco di Gentile e Giovanni Bellini e lo Sposalizio della Vergine di Raffaello e tanti altri: nel 1815 la Pinacoteca conta già 800 opere, che però verranno restituite alle loro sedi originarie con la caduta di Napoleone. Fine della storia? Al contrario: Brera dovrà attraversare periodi ben più difficili, cadendo e risorgendo, come una fenice, ben due volte. La prima dopo la distruzione durante la Seconda Guerra Mondiale, la seconda, negli anni Settanta, dopo cinque anni di chiusura per mancanza di fondi. Risale proprio a quell’ultima crisi, di spazi e di denaro, il progetto di ampliamento conosciuto come Grande Brera e che proprio in questi mesi ha preso inizio: l’Accademia di Belle Arti diventerà un vero e proprio campus universitario con 14 mila metri quadrati di aule ricavate da una ex caserma, mentre la Pinacoteca si allargherà a Palazzo Citterio (9.500 metri quadrati), trasferendo qui parte delle sue collezioni. E allora non ci saranno più scuse: Brera dovrà ricominciare a battere tutti i precedenti record di affluenza, come i 12 mila visitatori registrati in un solo giorno, il 15 agosto del 2009, arrivati un po’ per festeggiare i duecento anni dall’apertura e un po’ perché l’ingresso era gratuito. Del resto la collezione non ha paragoni in Italia e all’estero: la più ricca e approfondita raccolta di pittura veneta e lombarda del Quattro e Cinquecento, infatti, si trova qui e non altrove, da Andrea Mantegna col suo celeberrimo Cristo morto ai capolavori di Giovanni Bellini, Tiziano, Tintoretto o Veronese, così come alcune fra le tele più conosciute, fotografate e riprodotte al mondo, il già citato Sposalizio della Vergine di Raffaello, il Cristo alla colonna di Bramante e la Cena in Emmaus di Caravaggio. Tutti dipinti che gli altri musei, dal Louvre di Parigi alla National Gallery di Londra, invidiano a Milano. Ma non solo: per farsi un’idea della pittura italiana dell’Ottocento, un turista che arrivi in Italia deve per forza mettere da parte gli Uffizi e fare tappa prima in via Brera 28 per ammirare alcune correnti di nicchia come i macchiaioli (Giovani Fattori), i divisionisti o i simbolisti (Segantini e Previati) oppure lasciarsi travolgere dalla grande Fiumana di Giuseppe Pellizza da Volpedo (il più noto Quarto Stato però, è al Museo del Novecento, accanto al Duomo) e dal celeberrimo – e copiatissimo – Il Bacio di Francesco Hayez, che tra l’altro fu anche professore di disegno proprio all’Accademia di Belle Arti.
APPROFONDIMENTI | |
Senza dubbio un patrimonio di inestimabile valore, che però ha molto potenziale inespresso e tutto da valorizzare. Come? È l’obiettivo sfidante di Sandrina Bandera, soprintendente e direttrice, che parla della “sua” Pinacoteca con orgoglio e in termini di una vera impresa, capace di fare (e stupire) anche in periodi difficili, con pochi mezzi, ma molto impegno e innovazione. «Il bilancio della Pinacoteca è in attivo», racconta, «se si tiene conto del numero dei visitatori, in recupero dopo due anni di crisi, dei restauri, con le opere di tutela e conservazione del patrimonio, e infine delle attività culturali, come mostre, conferenze e attività scientifiche, che sono il vero ossigeno del museo». Vero: qui arrivano professori da tutto il mondo, migliaia di turisti, allievi dai quattro angoli della terra. Sono attratti dal prestigio di Brera, un’istituzione senza eguali nel panorama artistico mondiale, ma anche l’unico caso al mondo (ci piacerebbe venire smentiti) di museo di prim’ordine senza neppure una caffetteria. Se non ci fosse un bar al Louvre, la notizia andrebbe sui giornali.
© Riproduzione riservata