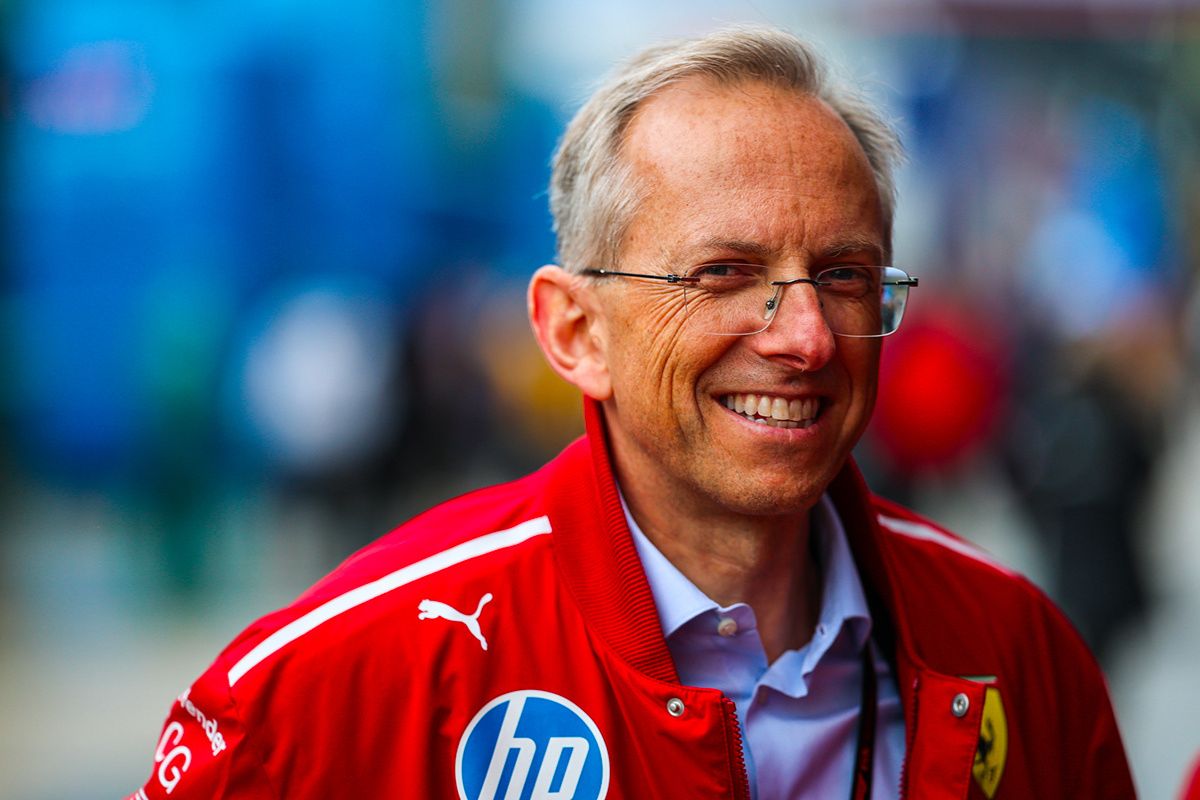Avete presente l’Africa? Quella attraversata da guerre, carestie, cataclismi naturali? Scordatela. C’è un’altra Africa che sta fiorendo grazie all’energia. Ma non quella del petrolio, è quella verde dei pannelli solari che potrebbe dare un’occasione di sviluppo al continente. Ovvio, siamo agli inizi e certo l’economia pulita potrà fare poco senza la volontà politica di fare uscire l’Africa dal sottosviluppo, ma è interessante notare che uno sviluppo alternativo è possibile. Il punto è far sì che vada a vantaggio di tutti e non dei soliti oligarchi. I fattori che hanno attirato l’attenzione degli investitori sull’Africa sono la disponibilità di ampie aree di terra a basso prezzo e condizioni climatiche ideali per le aziende verdi. Se aggiungiamo i flussi di capitale dalla Banca Mondiale e dai Paesi industrializzati solo il vertice di Copenhagen ha stanziato 30 miliardi di dollari per il triennio 2010-2012 – emerge una realtà in straordinario fermento.
Il Sahara come alleatoI progetti per trasformare l’Africa in un continente “verde” non mancano. Si va dai villaggi ecosostenibili fino al programma di produrre energia attraverso i pannelli solari piazzati nel deserto del Sahara. Questo, in particolare, è il progetto Desertec, nato dagli studi del premio Nobel Carlo Rubbia, e sviluppato attraverso la cooperazione tra Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Giovanni De Paoli, ricercatore dell’Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) spiega: «Gli studi svolti dal Centro tedesco di ricerca aerospaziale Dlr hanno dimostrato che centrali solari termodinamiche ed eoliche, disposte su meno dello 0,3% della superficie dei deserti, sarebbero in grado di generare elettricità e acqua potabile in quantità tale da coprire la domanda di Europa, Medio Oriente e Nord Africa». Non male, vero? Il Desertec Project da solo dovrebbe essere in grado di fornire all’Europa il 15% del suo fabbisogno energetico entro il 2050 con investimenti per 400 miliardi di euro. Le prime aziende ad avervi preso parte sono Deutsche Bank, E.On, Munich Re e Siemens. E non sono le uniche iniziative in campo: due aziende italiane, Techint Italia e Gengroup, per esempio, stanno progettando in collaborazione con Enea una grande centrale solare termodinamica per la dissalazione dell’acqua in Libia. Sarà particolarmente efficiente grazie a componenti prodotte dall’azienda umbra Archimede Solar Energy di cui Siemens ha rilevato, nel marzo del 2009, il 28%. Il colosso tedesco stima, infatti, per il mercato delle centrali solari termodinamiche, un valore di oltre 10 miliardi di euro entro il 2015 con tassi di crescita annui a due cifre. Gran parte di questo boom riguarderà il’Africa anche grazie ai fondi delle istituzioni internazionali. La Banca Mondiale per esempio investirà 5,5 miliardi di dollari in nuove centrali termoelettriche in Tunisia, Algeria, Marocco, Giordania ed Egitto.
Dimenticare CopenhagenE qui spunta un paradosso: i Paesi africani, accusati di ostruzionismo sulle questioni ambientali, si rivelano, in realtà, protagonisti nella lotta al surriscaldamento terrestre dal quale sono proprio loro i primi a subire le peggiori conseguenze: secondo Greenpeace, un aumento della temperatura di tre gradi sarebbe sufficiente a estendere le aree aride e semiaride in Africa tra il 3% e il 5%. Di fronte a questi dati l’impressione è che il continente lasci alle multinazionali le decisioni strategiche riguardanti il proprio futuro e non sia in grado di prendere in mano la leadership della lotta ai cambiamenti climatici. Dai Paesi africani è partita a dicembre l’opposizione ai vincoli all’inquinamento proposti da Stati Uniti e Unione Europea alla Conferenza delll’Onu di Copenhagen. I Paesi in via di sviluppo e la Cina hanno abbandonato le trattative e sono tornate al tavolo di negoziati solo una volta stabilita l’entità dei fondi per coprire i costi dell’adattamento ai cambiamenti climatici e l’abolizione dei meccanismi di verifica e sanzione per il mancato rispetto dei vincoli. All’origine vi è la convinzione che i Paesi industrializzati dopo aver costruito la propria ricchezza con tecnologie inquinanti vogliano frenare lo sviluppo dei Paesi emergenti (che utilizzano gli stessi processi produttivi che hanno arricchito l’occidente) fissando alti standard ambientali. Come spiega Alberto Piatti, segretario generale della ong Avsi: «In fondo noi europei raccogliamo i frutti di 2 mila anni di storia e non è in alcun modo giustificato teorizzare improbabili scorciatoie per gli altri popoli».Il risultato è stato un accordo debole, che si limita all’impegno di tenere il riscaldamento globale sotto la soglia di due gradi centigradi entro il 2015: il limite che gli scienziati dell’Onu ritengono il massimo livello oltre il quale i cambiamenti climatici avrebbero effetti drastici e irreversibili. Un accordo debole che ha fatto scrivere al premio Pulitzer Thomas Friedman sul suo blog che «il solo motore forte a sufficienza per essere efficace contro Madre Natura è Padre Avidità: il mercato. Soltanto un mercato regolato con principi e incentivi in grado di stimolare l’innovazione delle fonti di energia pulite e rinnovabili può intaccare il processo del riscaldamento globale». Si tratterebbe di stabilire quali siano le giuste regole e i corretti incentivi.
Sviluppo o colonialismo?Già, le regole. I primi tentativi di investimento in un’altra tecnologia verde, quella dei biocarburanti, hanno mostrato infatti problemi rilevanti. Paesi poveri hanno destinato terreni fertili alla produzione di energia espropriando a volte interi villaggi delle loro terre e facendo aumentare i prezzi del cibo. Il produttore di bioetanolo svedese Sekab, dopo aver investito in Africa quasi 20 milioni di euro tra il 2005 e il 2008, ha dovuto rinunciare e ha venduto le sue attività in Tanzania in seguito a polemiche che hanno coinvolto anche il Wwf. La stessa Banca Mondiale ha affermato la necessità di un nuovo approccio alla produzione di biocarburanti che consenta di aumentare la produttività dei terreni in modo da non sacrificare la produzione alimentare e di trattenere parte del reddito prodotto nella regione, per esempio con investimenti nelle infrastrutture. La norvegese Biofuel Africa ci ha provato con il progetto Food First (il cibo prima di tutto). Secondo l’amministratore delegato Steinar Kolnes «non c’è stata alcuna riduzione nella produzione di cibo a seguito delle nostre attività in Ghana, dove abbiamo investito 11 milioni di dollari. Al contrario, abbiamo facilitato la crescita delle terre a disposizione dei coltivatori diretti grazie alle nostre macchine e tecnologie». Dal 2003 gli ettari utilizzati per la produzione di alimenti nella regione sono passati da 22 a quasi 220. Insomma, gli affari “verdi” in Africa si possono fare e le multinazionali non sono per forza distruttori di civiltà. Lo ha riconosciuto anche Bob Geldof, musicista e ideatore dei concerti di beneficienza Live Aid: «Investire in agricoltura in Africa è fondamentale e può anche essere molto redditizio. Il continente ha una classe media in crescita e 900 milioni di produttori e consumatori ed è il posto dove, nei prossimi decenni, ci sarà un ritorno di investimento tra i migliori al mondo. Dobbiamo accompagnare questi popoli, per la salvezza della nostra economia e del nostro ambiente globale». Discorso un po’ troppo “buonista” secondo Business Week che ha parlato dell’Africa come di un campo di battaglia per i biocarburanti dove si affrontano Paesi Bassi, Stati Uniti, Svezia, Giappone, Canada e Germania in un nuovo “conflitto coloniale” che al momento avrebbe come primo obiettivo la Tanzania. La britannica Sun Biofuel, per esempio, avrebbe ottenuto dal governo l’utilizzo gratuito di 9 mila ettari (la superficie di circa 12 mila campi da calcio) per 99 anni. A Business Week le grandi piantagioni di biocarburanti nelle campagne africane ricordano gli immensi campi monocoltura come quelli coltivati a caffé, che storicamente hanno impoverito le terre e i loro abitanti. Lo spiega bene Alberto Piatti dell’Avsi: «Le grandi coltivazioni intensive allontanano le famiglie dai terreni, sfruttano il suolo, rompono gli equilibri dei cicli naturali, non costruiscono saperi, se non tecniche di maggior sfruttamento per un guadagno di breve termine. Invece, il lavoro della famiglia rurale, attraverso il quale l’Europa è cresciuta ed è divenuta ciò che è oggi, è la fonte di un lento ma continuo sviluppo della persona e insieme della natura. È cura del suolo, è cura dei corsi d’acqua e dei mari, è trasformazione dei frutti, è rispetto dei cicli naturali, è ricerca, è biologia, è ingegneria».
Si può fareLa Banca Mondiale indica una strada per conciliare la lotta ai cambiamenti climatici con quella alla povertà e alla malnutrizione attraverso il concorso Development Marketplace, il “mercato dello sviluppo”. Negli ultimi anni diversi progetti africani sono stati premiati; uno riguarda l’autoproduzione di biocarburanti da parte delle aziende agricole in Senegal, un altro l’impiego dei rifiuti alimentari per l’allevamento delle capre in Nigeria. Quello che fa la differenza, alla fine, è la prospettiva di lungo termine che guarda alle persone e al complesso degli effetti generati da un’iniziativa. E non solo al conto economico della prossima trimestrale.
INVESTIMENTI ONU30 miliardi di dollari l’anno dal 2010-2012 per contrastare gi effetti dei cambiamenti climatici
BANCA MONDIALE5,5 miliardi di dollariper costruire centrali termoelettriche
DESERTEC PROJECT400miliardi di euro per produrre energia nel deserto
© Riproduzione riservata